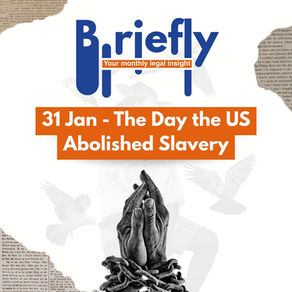25 Novembre – Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
- Legal Division
- 25 nov 2025
- Tempo di lettura: 5 min
Il 25 novembre non è solo memoria, ma misura del nostro progresso giuridico e civile. Dal “matrimonio riparatore” alla tutela della libertà femminile: un percorso nato dal coraggio di dire no.
Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, occasione di riflessione e sensibilizzazione su un fenomeno la cui ricorrenza continua a crescere drammaticamente. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale, nel 2025 sono stati registrati 91 casi tra femminicidi, suicidi indotti e violenze di genere, oltre a 67 tentati femminicidi. Le vittime avevano un’età compresa tra 1 e 93 anni, in almeno 12 casi vi erano già denunce o segnalazioni per violenza o stalking. Quindici donne avevano una disabilità o una malattia grave, mentre 10 minori hanno assistito al femminicidio e 55 sono rimasti orfani. La maggioranza dei responsabili si è tolta la vita, impedendo il corso della giustizia. Tra i 78 omicidi accertati, 26 sono avvenuti per accoltellamento, 14 per arma da fuoco, 17 per strangolamento o soffocamento; altri per percosse o cadute provocate. Questi racconti delineano una realtà che non può essere considerata episodica: non si tratta di aggressioni sporadiche o raptus isolati, ma di un fenomeno, radicato e sistemico, manifestato con inquietante costanza, che riflette disuguaglianze di genere storicamente consolidate e che rischia di divenire parte della nostra quotidianità. Contrastare questa violenza è un dovere collettivo da attuare attraverso un dialogo sociale e mediatico, che ad oggi troppo spesso ne minimizza le gravità, umanizza i carnefici e mette in ombra le vittime. Occorre un impegno costante, capace di ristrutturare in profondità il nostro tessuto culturale e le sue narrative anacronistiche che contribuiscono a rendere invisibile la sofferenza femminile, normalizzandone l’impatto.
Un progresso autentico passa attraverso azioni concrete, che concilino, in via principale, l’educazione alla parità e il rafforzamento dei percorsi di tutela, affinché prevenzione, protezione e consapevolezza diventino strumenti reali, accessibili e duraturi per affrontare la violenza di genere. E questo, un vero progresso che passi attraverso azioni, è in ogni modo e luogo possibile ed auspicabile. Ce lo dimostra il caso di Franca Viola, il cui nome è diventato simbolo di emancipazione e di rottura con una cultura che da sempre subordinava le donne all’onore familiare e alla morale collettiva. La sua storia, accaduta nella Sicilia degli anni Sessanta, rappresenta una svolta non soltanto per il diritto, quanto piuttosto per la coscienza civile del nostro Paese.
Nel 1965 Franca, allora diciassettenne, fu rapita e violentata da Filippo Melodia, ex fidanzato appartenente a bande mafiose. Il fidanzamento tra i due era stato rotto in passato dal padre di Viola, proprio perché non accettava la vicinanza alla criminalità del ragazzo; Melodia, figlio di un sistema sociale complice, rifiutò la rottura e si vendicò con il rapimento della ragazza. Egli contava di poter poi “riparare” al danno contraendo matrimonio. Era questa, infatti, la consuetudine legittimata dall’allora normativa: si permetteva all’autore di un reato sessuale di estinguere la pena sposando la vittima. A tal proposito è bene ricordare che, in quel contesto, la violenza sessuale non era percepita come reato contro la persona, bensì come solo oltraggio alla morale. Il rifiuto di Franca Viola di contrarre quel matrimonio fu dunque un gesto rivoluzionario. In un’epoca in cui la voce femminile era ancora fortemente soffocata dal giudizio sociale, la sua decisione rappresentò una presa di posizione pubblica contro una cultura maschilista, della vergogna e del silenzio. Con il sostegno del padre, Franca scelse di difendere la propria posizione, rifiutando di essere ridotta a vittima da “redimere” con un atto riparatore. Il processo che seguì nel 1966 ebbe un forte impatto nazionale: per la prima volta una donna non consentì che la violenza subita potesse essere “sanata” dal matrimonio. Da allora, il suo caso è diventato un riferimento per il cambiamento culturale che ha preceduto, accompagnato e permesso le successive riforme legislative. Oggi, ricordare Franca Viola significa ricordare soprattutto l’origine della consapevolezza moderna sulla violenza di genere. La sua storia non appartiene solamente al passato: può parlarci ancora di libertà, di autodeterminazione, e del coraggio necessario per infrangere norme talvolta ingiuste. Nel contesto del 25 novembre, la sua vicenda può dimostrarci come ogni progresso giuridico nasca da un atto di coraggio umano — e quanto questo sia sempre necessario, e mai invano.
È dunque possibile dire che la sua scelta ha realmente aperto la strada a una lenta ma decisiva revisione del diritto, costringendo l’ordinamento italiano a misurarsi con la realtà della violenza di genere. Fino all’approvazione della legge 442/1981, infatti, l’ordinamento italiano prevedeva le cosiddette “attenuanti d’onore”. In particolare, l’art. 587 c.p. intitolato “Omicidio e lesione personale a causa d’onore” stabiliva che “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni”. Assieme a questo, l’articolo 544c.p sopramenzionato prevedeva che “il matrimonio che l’autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato”. Tali norme penali erano chiaramente il frutto della mentalità patriarcale e sessista dei tempi, derivando addirittura dall’originario codice rocco: come tali, esse entrarono rapidamente in contrasto con i principi costituzionali, tanto che la Corte Costituzionale dovette pronunciarsi presto su questioni di legittimità costituzionale riguardanti tali articoli. Già con la sentenza 126/1968 la Corte dichiarò incostituzionale l’art. 559 c.p nella parte in cui puniva solo l’adulterio della moglie e non quello del marito, mentre la sentenza 147/1969 abrogò del tutto il reato di adulterio. Risulta evidente come la battaglia fosse contro un'intera concezione del sistema penale, che da un lato penetrava eccessivamente nelle questioni private dei cittadini, mentre dall’altro soffriva di un inconciliabile contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza fra i sessi previsto dall’art.3, nonché con quello di “uguaglianza morale e giuridica” fra i coniugi. Non a caso, infatti, il Ministro di Grazia e Giustizia Oronzo Reale già nel 1968 propose un disegno di legge per eliminare le attenuanti d’onore, ma dovremo attendere la riforma del diritto di famiglia del 1975 per arrivare infine alla famosa l. 442/1981. Il caso italiano non è isolato: le “attenuanti d’onore”, riconosciute in vista di una certa ammissibilità sociale di azioni compiute in stato d’ira, erano previste già nel Codice Napoleonico, e come tali si sono diffuse a macchia d’olio in tutti i codici che da esso derivavano: basti pensare che in Turchia il delitto d’onore è stato abrogato nel 2005. Guardando il processo storico-culturale che ha portato a tale sviluppo, perlomeno in Italia, si nota chiaramente come questo sia uno dei casi in cui il diritto segue i mutamenti sociali, senza “crearli”: mentre, al contrario, gli sviluppi successivi al 1981 possono essere in parte interpretati come movimenti d’avanguardia. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito più volte come nessun moto di gelosia o d’onore può costituire in alcun modo un attenuante. Cass. n. 9254/1996 cita esplicitamente: “la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio ferito, costituiscono passioni morali riprovevoli insuscettibili di valutazione positiva”. Numerose sentenze successive, come cass. n. 9590/1997, sottolineano come tale orientamento si sia consolidato, arrivando a trasformare le “attenuanti d’onore” in qualcosa che viene percepito al massimo come un motivo per punire più severamente, non meno: in tale ottica si sono mossi chiaramente i progetti normativi riguardo all’introduzione del reato di femminicidio, o di aggravanti per la presenza di circostanze familiari. Da ultimo, è importante considerare come si sia evoluta l’interpretazione giurisprudenziale dell’attenuante della provocazione, prevista all’art. 62.2 del c.p. Esso prevede che la pena sia ridotta se l’imputato abbia agito in uno stato d’ira provocato da un fatto ingiusto altrui: in origine, il caso di scuola era proprio quello della flagranza di adulterio (cfr. dottrina americana dell’Heat of passion), mentre ora la Corte di Legittimità ha chiaramente affermato che l’infedeltà, in sé, non può giustificare reazioni violente. (Cass. 2725/2020) Casi come quello del delitto d’onore sottolineano appieno quanto diritto e società siano strettamente connessi fra loro, e mettono in luce quanto un’analisi giurisprudenziale possa essere utile anche allo storico per comprendere appieno i mutamenti sociali che hanno attraversato una data epoca.
di A. Sussetto, R. Marincola, C. Baylon, G. Buffa